Era una sera di inizio maggio di sedici anni fa, Salman Rushdie viveva a New York e finalmente si sentiva un uomo libero e al sicuro, erano passati vent’anni dalla fatwa annunciata per radio dall’ayatollah Khomeini, con cui veniva condannato a morte per aver scritto un romanzo – “I Versi Satanici” – accusato di insultare l’Islam e Maometto. Roberto Saviano invece aveva solo 28 anni e ancora non si era abituato a vivere sotto scorta, colpevole anche lui di aver scritto un libro “sbagliato”: “Gomorra”. Era arrivato a New York da poche ore. I due si incontrarono, era la prima volta, io ero con loro e fui testimone di un lungo dialogo sulla vita, le paure e i libri.

Sedici anni dopo Saviano vive ancora sotto scorta e, quando può, scappa dall’Italia per respirare, mentre la libertà spensierata di Rushdie si è interrotta la mattina del 12 agosto 2022 mentre si trovava sul palco del Chautauqua Institution, nel Nord dello Stato di New York. Stava per cominciare una conferenza che non si sarebbe mai tenuta: un uomo vestito di nero e mascherato si gettò su di lui e cominciò a colpirlo con un coltello al collo, al petto e al volto. Rushdie è sopravvissuto ma ha perso un occhio e l’uso della mano sinistra. Oggi quella storia e il calvario dei mesi di cure è raccontata in un libro intitolato “Coltello. Meditazioni dopo un tentato assassinio”. Un racconto potente, una cronaca dettagliata e minuziosa su sé stesso:
«L’anfiteatro dispone di oltre 4000 posti a sedere. Non era pieno, ma c’era tanta gente. Io ero seduto sul lato destro. Il pubblico ha applaudito con entusiasmo. Ricordo di aver alzato la mano in segno di ringraziamento. A quel punto, con la coda dell’occhio destro – l’ultima cosa che il mio occhio destro avrebbe visto – ho scorto l’uomo in nero che correva verso di me lungo il corridoio alla destra della platea. Vestito di nero, con una maschera nera. Avanzava veloce a testa bassa: un missile rasoterra. Mi sono alzato in piedi e osservato la sua progressione. Non ho tentato di fuggire. Sono rimasto pietrificato.
Erano passati 33 anni e mezzo dalla famigerata sentenza di morte emessa dall’ayatollah Ruhollah Khomeini contro di me e contro chiunque avesse avuto a che fare con la pubblicazione dei miei Versi Satanici, e in tutto quel tempo, lo confesso, mi era capitato più volte di immaginare un aggressore che, in occasione di un qualche evento pubblico, mi veniva incontro dalla platea proprio in quel modo. Di conseguenza, alla vista di quella sagoma assassina lanciata contro di me, il mio primo pensiero è stato: “Sei tu, dunque. Eccoti qui”. La morte stava arrivando anche da me, ma non mi sembrava tanto distinta, quanto piuttosto anacronistica.
Il mio secondo pensiero, infatti, è stato: “Perché ora? Davvero? È passato così tanto tempo. Perché proprio adesso, dopo tutti questi anni?”. Il mondo era indubbiamente cambiato, e quella questione era chiusa. Eppure, in quel momento, c’era una sorta di viaggiatore del tempo che avanzava rapido verso di me, un fantasma assassino giunto dal passato.
Quella mattina non c’erano misure di sicurezza visibili nell’anfiteatro -perché? Non ne ho idea-, ragion per cui quell’uomo ha avuto campo libero. Io me ne stavo lì immobile a fissarlo, inchiodato sul posto come un idiota, un coniglio abbagliato dai fanali di un’auto. In un attimo mi ha raggiunto».

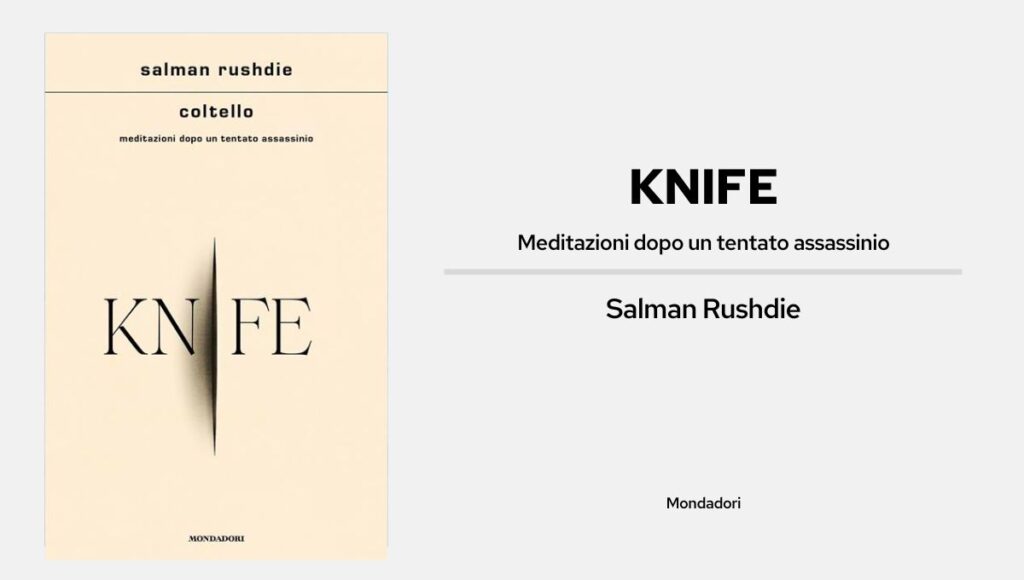
Venerdì prossimo a Torino, al Salone del Libro alle 18:30, Salman Rushdie presenterà questo suo nuovo libro proprio insieme a Roberto Saviano. Per questo vi propongo il pezzo che avevo scritto sedici anni fa per Repubblica. Le loro parole sono ancora oggi attualissime.
Salman Rushdie, 60 anni, romanziere angloindiano, condannato a morte dall’ayatollah Khomeini per aver scritto nel 1988 “I Versi Satanici”: più di dieci anni passati nascondendosi, viaggiando su auto blindate, con otto uomini di scorta.
Roberto Saviano, 28 anni, giornalista e scrittore napoletano, vive blindato da 19 mesi, cambiando continuamente domicilio da quando si è scoperto un progetto per eliminarlo del clan camorristico dei Casalesi. La sua colpa? Aver scritto il libro “Gomorra”, tradotto in 42 Paesi.
Salman Rushdie si avvicina a Roberto Saviano, gli sorride, si presenta, lo abbraccia e subito gli chiede: «Hai la scorta anche qui?». «Sì, me l’ha data l’FBIi: tutti agenti italoamericani si occupano di mafia e traffici internazionali». «Io invece non ho più la scorta, qui in America sono tornato ad essere un uomo libero».
Inizia così, con un incontro casuale in una casa privata, un lungo dialogo che parla di vite rubate, della paura, della solitudine, delle minacce, della libertà di scrivere e della speranza di recuperare una vita normale. Saviano ha un girocollo di lana blu, i jeans e le scarpe da tennis. Rushdie una giacca scura con un golf grigio e un paio di scarpe nere. Sono entrambi a New York per il Festival internazionale di letteratura “PEN World Voices”. I due parlano fitto come si conoscessero da tempo, si mettono in un angolo, come non volessero disturbare con le loro storie angosciose. In mezzo a loro una gallerista newyorkese, Valentina Castellani, che si trova a fare per caso da traduttrice. Rushdie ha conosciuto Gomorra grazie ad un suo amico napoletano, il pittore Francesco Clemente, e aveva mandato a Saviano una mail di solidarietà quando aveva saputo delle prime minacce. È lui a dare il ritmo al dialogo, lo tempesta di domande, vuole capire se quel ragazzo che ha davanti sta ripetendo esattamente il suo calvario.



Saviano: «Alcuni hanno paragonato le nostre vite: un libro ci ha condannati a vivere sotto scorta, condannati a morte. Ma io vedo una differenza fondamentale tra noi: tu sei stato minacciato per il solo fatto di aver scritto, nel momento in cui hai pubblicato è arrivata la fatwa. Per me è stato diverso, quello che non mi hanno perdonato non è il libro ma il successo, il fatto che sia diventato un bestseller. Questo li ha disturbati e più la cosa diventa nota e più sono incazzati con me».
Rushdie: «No, invece penso che alla fine sia la stessa cosa, comunque ti hanno preso di mira perché hai scritto qualcosa che non volevano, che ha dato fastidio».
Poi però Rushdie si blocca, si incuriosisce, vuole sapere di più: «Ma perché, davvero all’inizio non hai avuto problemi?».
Saviano: «No. Se il libro fosse rimasto confinato al paese, a Napoli, alla mia realtà locale, allora gli andava anche bene, anzi, i camorristi se lo regalavano tra loro, contenti che si raccontassero le loro gesta. Avevano perfino cominciato a farne delle copie taroccate da vendere per la strada e un boss aveva rimesso le mani in un capitolo riscrivendosi alcune parti che lo riguardavano».
Rushdie si mette a ridere e dice: «Magnifica l’idea che un mafioso si metta a fare l’editing di un libro. Mi fa venire in mente una cosa incredibile che è accaduta al giornalista indiano Suketu Mehta. La prima volta che è tornato a Bombay, dopo aver scritto Maximum City, è stato chiamato dai gangster mafiosi di cui parla nel libro: volevano lamentarsi con lui perché gli aveva cambiato i nomi, mentre ai poliziotti aveva lasciato quelli originali. Insomma, volevano apparire ed erano dispiaciuti di non poter essere facilmente identificati».
Saviano: «Poi però la cosa è cresciuta, si è cominciato a parlare del libro e questo ha cominciato a disturbarli. Perché fino ad allora non finivano mai sulla prima pagina dei giornali, neppure quando facevano massacri, e si sentivano tranquilli e riparati. Poi il libro ha risvegliato l’attenzione in tutta Italia e questo successo non mi è stato perdonato».
Rushdie: «E ora come vivi?».
Saviano: «Sempre sotto scorta dei carabinieri, cambio casa continuamente, non ho più un’esistenza normale».
Rushdie: «Hai problemi solo tu o anche la tua famiglia?».
Saviano: «La mia famiglia se n’è dovuta andare da casa e aver creato loro questi problemi mi pesa molto».
Rushdie: «Invece io sono stato l’unico ad aver avuto una vita blindata, la mia famiglia non è mai stata minacciata e ha continuato a vivere come prima, mia madre allora stava in Pakistan e nessuno le ha mai fatto nulla. Adesso viaggi sempre sotto scorta?»
Saviano: «Sì, in ogni momento, anche quando vado all’estero».
Rushdie: «Anch’io sono stato scortato in Italia e ricordo una paura terribile, i poliziotti avevano sempre la pistola in mano, guidavano come dei matti e io temevo che avremmo ammazzato qualcuno. La verità è che ad un certo punto non vivi più, sei prigioniero delle minacce, di chi ti vuole uccidere e di chi ti protegge. Non ti fanno fare più nulla e ti sembra di impazzire, non sei più padrone della tua vita».
Saviano: «A me i camorristi hanno detto: ti abbiamo chiuso nella bara senza averti ucciso. Però per me la scorta non è qualcosa che mi tiene prigioniero e isolato, ma è l’unico modo per permettermi di continuare a lavorare e a scrivere».
Rushdie: «Devi riprenderti la tua libertà. Ascoltami bene Roberto, non arriverà mai un giorno in cui un poliziotto o un giudice si prenderanno la responsabilità di dirti: “È finita, sei un uomo libero, puoi andare tranquillo, uscire da solo”. Non succederà mai, sarai tu a doverlo decidere».
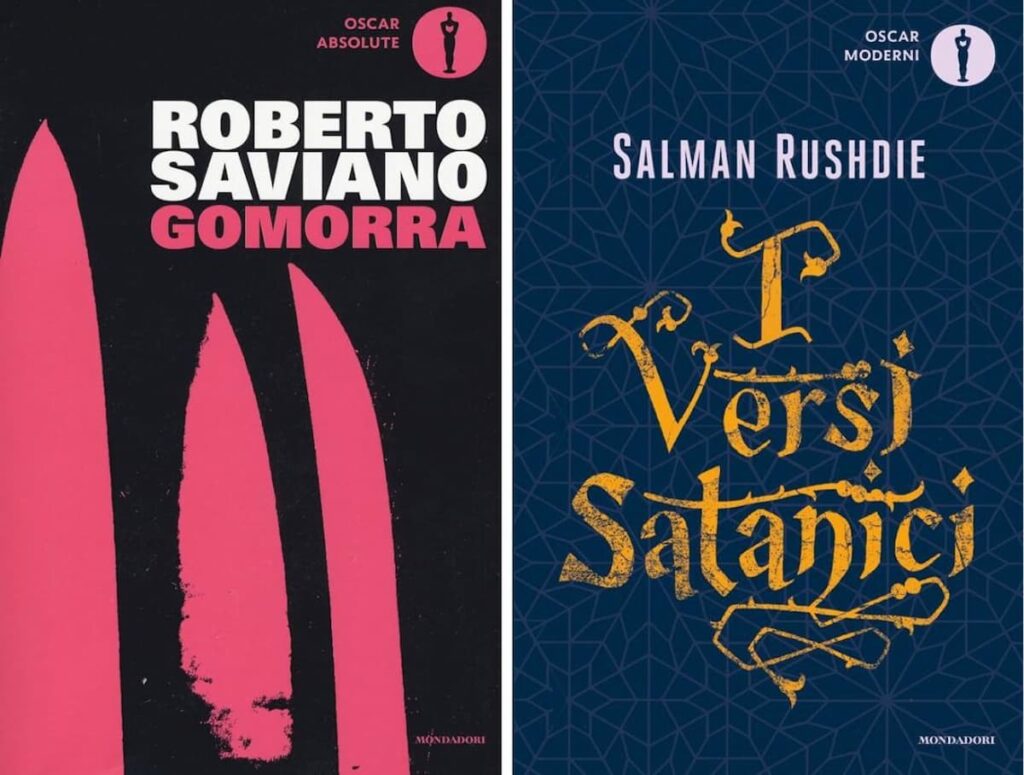


Rushdie resta fermo in silenzio a fissarlo, vuole essere sicuro che tutto venga tradotto con cura, che il suo messaggio sia chiaro, poi ricomincia, quasi stesse dettando un decalogo di sopravvivenza: «La libertà sta nella tua testa. Io certe volte chiedevo di presentare un libro o di andare ad una conferenza ma non mi autorizzavano, dicevano che era troppo rischioso. Ma se io mi sentivo che si poteva fare allora combattevo come un leone finché non ottenevo di poterci andare. Devi riappropriarti della tua capacità di giudicare cosa puoi fare, del tuo fiuto, della tua sensibilità, non puoi appaltare tutta la tua vita ai poliziotti».
Poi si ferma di nuovo, ha paura di aver esagerato: «Mi raccomando, non ti sto dicendo di fare cose imprudenti o avventate, non ti dico di andare a metterti davanti ad una pistola, ma di recuperare una libertà di giudizio. Io l’ho recuperata venendo a vivere qui negli Stati Uniti. Ricordo le prime volte a New York, scendevo da solo in metropolitana, camminavo nel Parco, andavo ad un museo. Poi tornavo a Londra e avevo l’auto blindata e otto uomini di scorta e mi mancava l’aria».
Saviano: «Certe volte mi sono interrogato se ne è valsa la pena, se quello che sto pagando non è sproporzionato rispetto ad un libro, soprattutto quando penso ai miei parenti, a quello che anche loro hanno passato e passano. Poi però non riesco a dirmi che non dovevo scriverlo e alla fine penso sempre che lo rifarei».
Rushdie: «Anche io ho sempre pensato che avrei riscritto “I Versi Satanici”. Ma perché il tuo libro ha dato più fastidio di altri, come te lo sei spiegato?».
Saviano: «Perché non è un saggio ma un racconto, è letteratura, e così ha raggiunto un pubblico molto più vasto, è stato letto da molta più gente e questo ha combinato il casino».
Saviano: «Comunque se non riescono ad eliminarti cercano di sporcarti, di danneggiarti, di raccontare che sei un poco di buono, un’infame, che lo fai perché sei un fallito e un invidioso».
Rushdie: «È vero, è così: ti squalificano. Per anni hanno sostenuto che io avevo scritto finanziato da lobby ebraiche, che ero il diavolo, un impostore, il male. Questa predicazione ha fatto proseliti: ci sono intere aree del mondo musulmano dove non posso andare o dove non potrei mai parlare perché ormai il pregiudizio contro di me è talmente radicato che non c’è più nulla da fare. Ma non possiamo mollare, bisogna andare avanti, continuare a scrivere, continuare a vivere».
Saviano: «È quello che sto cercando di fare, ma certe volte è dura, vedi le calunnie e le minacce e fai fatica a pensare ad altro».
Rushdie: «Potrai perdere oggi, potrai perdere per 30 anni ma alla fine vincerai tu, perché la verità alla fine vince sempre. Ricordati: la letteratura non è una cosa di oggi ma, come diceva Italo Calvino, è una cosa di tempi lunghi e su quelli si misurano le cose nella vita».



Saviano abbassa la voce: «Vorrei farti una domanda forse un po’ ingenua: ma pensi che la letteratura possa davvero disturbare il potere?».
Rushdie: «Assolutamente sì, continuo a crederci. Guarda con quanta attenzione i regimi controllano la letteratura e gli scrittori, pensa a come vigilavano in Unione Sovietica e ne avrai la prova».
Rushdie: «Stai scrivendo qualcosa di nuovo?».
Saviano: «Sì, un altro libro ma non sulla camorra».
Rushdie: «Bravo, continua a scrivere e scrivi anche di altro, anch’io ho fatto così, anche questo è un modo per non restare prigionieri. Devi recuperare una vita che non sia tutta legata a Gomorra. E poi dovresti venire a stare un po’ a New York, qui mi sono sempre sentito molto più libero che in Europa. Qui non potrebbe mai accadere che uno scrittore venga minacciato per un libro, forse perché in America nessuno pensa che la letteratura possa avere questo potere».
È ormai tardi, si salutano.
Rushdie: «Verrò a trovarti a Napoli il prossimo anno, ci sarà una mostra di Clemente e ci sarò sicuramente».
Poi scendono insieme, in ascensore si aggiunge il romanziere inglese Ian McEwan. Quando escono dal portone Rushdie vede gli uomini dell’FBIi e allora, divertito, dice a Saviano: «Lascia a me e a Ian l’onore di scortarti fino alla macchina». Poi, prima di chiudergli la portiera, gli ripete: «Roberto abbi cura di te, sii prudente, ma riprenditi la tua vita e ricordati che la libertà è nella tua testa».
L’auto blindata dei federali parte veloce. Rushdie, da solo, si mette a camminare nella notte lungo il Central Park.



